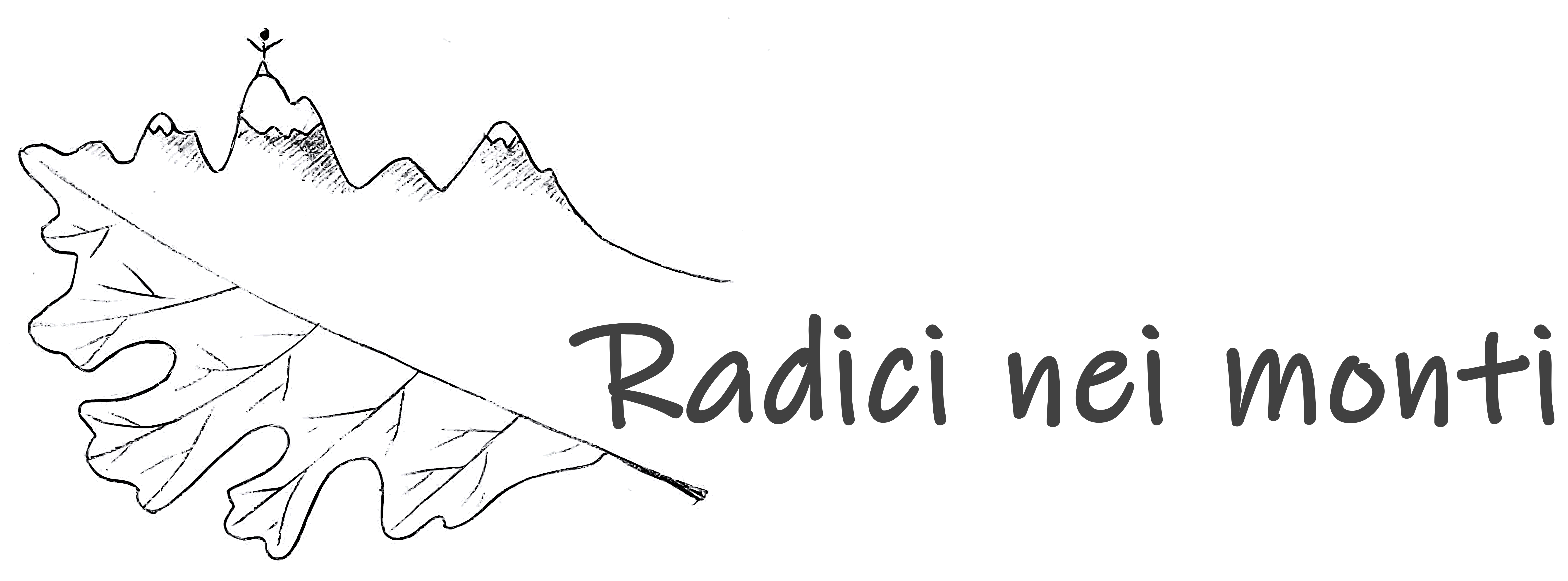Era una sera di qualche inverno fa. Ricordo che la neve era caduta copiosa e pesante qualche giorno prima. I miei rami e quelli dei miei compagni intorno la sorreggevano a stento. Quella sera il silenzio era assoluto, come spesso capita d’inverno tra questi monti, quando quasi tutti gli animali, uomini compresi, scendono a valle per trascorrere i mesi più freddi. D’un tratto, però, tutto era cambiato. Un vento potente venuto da lontano aveva cominciato a scuoterci sempre più forte. Soprattutto i primi di noi, gli alberi al margine del bosco, cercavano coraggiosi di resistere alle sferzate continue, come di fronte ad un imponente esercito nemico rimasto appostato in attesa dell’ora propizia per sferrare l’attacco decisivo. Erano, gli alberi al margine, i più resistenti, cresciuti con più luce, rispetto a noi all’interno del bosco.
Ricordo che ci avevano piantati tutti insieme, ormai almeno quaranta primavere fa. Eravamo stranieri venuti da lontano. Avevo sentito qualcuno chiamarci “douglasie” e dire che eravamo simili agli abeti, ma con gli aghi che profumano di limone. Insomma, eravamo ospiti in queste montagne dell’Appennino e i cerri, quelle grandi querce attorno a noi, che qui erano di casa insieme agli aceri, ai carpini e ai faggi appena più in alto, subito l’avevano messo in chiaro.
Eravamo nati in un qualche vivaio forestale e qui ci avevano portato gli uomini. Ci sentivamo compagni e fratelli, ma anche avversari: se qualcuno intorno a noi fosse cresciuto più in fretta e con più rigoglio ci avrebbe lasciato in ombra, togliendoci le nostre risorse vitali e presto sarebbe stata per noi la fine. Per questo allungavamo sempre di più i nostri fusti. Nella lotta per la sopravvivenza non potevamo permetterci di far crescere grossi rami tutti attorno o uno spesso fusto: eravamo fitti e dovevamo puntare in alto, per non perdere il nostro spazio di luce. Crescevamo in un terreno duro e sassoso, “Pietramala” lo chiamavano gli uomini quando passavano con le zappe per fare i solchi dove ci avrebbero piantato. Le nostre radici faticavano ad allungarsi in profondità per cercare acqua e nutrimento, tra tutte quelle pietre. Negli anni, dunque, erano rimaste corte e superficiali rispetto alla nostra altezza, che ormai superava i venti metri.

Quella sera in cui il vento ci aveva raggiunto impetuoso, per noi era stato un inferno. Di continuo sentivamo rami spezzarsi, già sfiancati per la neve pesante dei giorni prima. I nostri compagni al margine resistevano, ma non riuscivano a fare da scudo alle folate più forti, che s’infiltravano nel bosco, si scontravano contro i nostri fusti e ci facevano oscillare ed oscillare ancora. Noi, così alti e filati, senza quasi radici, non eravamo pronti a resistere ad una tale potenza. Molti dei miei compagni caddero quella notte. Mai potrò dimenticare quel rumore infernale di rami e tronchi spezzati. Era la voce del vento che forte si faceva sentire. Con le radici così corte eravamo deboli, non riuscivamo a stare ancorati a terra, a resistere alle sferzate. D’un tratto, un albero vicino a me cadde proprio nella mia direzione. Centrò in pieno la mia cima e mi spezzò, lasciandomi solo il fusto, dritto per un’altezza di una decina di metri.

Alle prime luci dell’alba lo spettacolo era desolante. Come un campo di battaglia, la vittoria di certo era del vento. Tanti alberi miei compagni erano caduti, tutti accavallati uno sull’altro. Pochi erano i superstiti di quella devastazione. Incredibilmente quelli di noi più al margine, che avevano potuto crescere più forti, avevano riportato meno danni.
Sembrava la fine.
Passò il tempo, le giornate cominciarono ad allungarsi, sui rami degli alberi intorno cominciarono a posarsi le prime cince che ripresero a cantare dopo il silenzio del gelido inverno.
Fu in quel tempo che cominciò ad accadere qualcosa. Lì dove le radici sdradicate avevano formato buche e smosso la terra, cominciarono a spuntare piccoli gerani di bosco, stellarie dai fiorellini bianchi ed altre piantine, i cui semi erano dormienti nel terreno da chissà quanto tempo. Nelle radure liberate da noi douglasie cresciute fitte e ombrose, filtrava ora di nuovo luce e lì spuntarono anche altri germogli. Non erano erbe, erano piccoli aceri i cui semi erano stati portati dal vento e avevano atteso il momento giusto per nascere. Ora, con lo spazio liberato dalla caduta dei mei compagni alberi, il momento era arrivato e non si erano fatti sfuggire l’occasione.

Già un grande acero di monte imponente cresceva tra noi. Lui era un montanaro originario di queste zone, conosceva bene questo terreno sassoso ed era cresciuto forte e resistente. Il vento di quella notte d’inverno non l’aveva affatto spaventato, mentre aveva spezzato me e le altre douglasie come me intorno. Forse quel grande acero era la madre dei piccoli germogli che ora spuntavano nelle nuove radure.
Un giorno, poi, avevo visto saltellare da un ramo all’altro un piccolo scoiattolo. Portava tra le zampe gherigli di noce e qualcuno gli era caduto proprio in quelle stesse radure. Ecco che allora anche da quei semi erano germogliate nuove piantine che approfittavano del terreno smosso, della luce e dello spazio.
Stupito osservavo, giorno dopo giorno, quel rinascere della vita nella devastazione di un bosco abbattutto dal vento. Ma non sapevo che ancora molto mi attendeva.

Una mattina presto, sempre in quella primavera, vidi passare per la prima volta la volpe, che nei giorni imparai a conoscere bene. Spesso, infatti, tornava. Le piaceva attraversare quel groviglio di alberi e rami caduti, a volte vi si nascondeva o vi sostava per riposarsi. Ma la volpe non era l’unica ospite del bosco. Spesso durante la notte vedevo passare dei cinghiali, prima erano una coppia, poi si erano aggiunti quattro piccoli striati, nati da poco. Usavano alcune buche formate dallo sdradicamento degli alberi come piscine di fango. Ci sguazzavano dentro e mi pareva lo facessero per pulirsi dai parassiti, anche se può sembrare strano. Percorrevano sempre la stessa traccia, fino a formare come un sottile sentiero. Da lì passava spesso anche un giovane capriolo maschio, con il palco ancora rivestito di velluto. Ogni tanto si fermava a brucare qualche stelo d’erba che nasceva nelle piccole radure. Una notte su quella stessa traccia vidi passare anche un lupo silenzioso, pareva fiutasse l’aria alla ricerca delle sue prede. Ma lo vidi solo quella volta e mai più.

Passavano gli anni e il mio legno s’indeboliva sempre di più. Un curioso insetto cominciò a deporre le sue uova sotto la mia corteccia. Aveva ali ricoperte da una corazza scura e brillante e due lunghe antenne sul capo. Quando le uova si schiusero, le larve di quell’insetto cominciarono pian piano a scavare gallerie per nutrirsi del mio stesso legno. Vedevo accadere lo stesso nei tronchi spezzati a terra, mentre io ero ancora in piedi, anche se con la cima spezzata e senza più foglie da quella notte di grande vento. Un giorno arrivò anche uno strano uccellino che non avevo mai visto prima. Aveva un forte becco e cominciò a scalfire la mia corteccia per nutrirsi delle larve degli insetti al suo interno. Il picchio, così decisi di chiamarlo per il suo continuo picchiettare, si trovò particolarmente bene sul mio fusto perché oltre a fare piccoli fori per nutrirsi, cominciò di buona lena a scavare un foro più grosso e profondo e lì vi depose le sue uova. Devo confessare che mi commossi quando sentii i primi pigolii dei piccoli picchi appena nati provenire dal nido.
Il forte vento che la notte di alcuni inverni prima mi aveva spezzato, mi aveva fatto diventare la casa di tanti organismi diversi e questo per me era motivo di grande gioia.
Lo stesso avveniva per i fusti spezzati a terra e per i rametti più piccoli, che pian piano si stavano degradando. Su alcuni crescevano muschi, licheni e funghi; col tempo poi, decomponendosi, quei legni andavano ad arricchire il suolo di nutrienti. Su una catasta che un uomo buono e saggio aveva lasciato al margine del bosco, ogni tanto nelle giornate estive sostava un bel ramarro verde brillante, mentre di notte ci correvano in mezzo i ghiri che poi agili si arrampicavano sui rami degli alberi attorno.

Intanto, le piantine degli aceri nelle radure continuavano a crescere, affiancate anche da piccoli cerri, andandosi a sostituire a quelli di noi che erano caduti: il bosco naturale di queste montagne si stava rinnovando riprendendosi lo spazio occupato anni prima da noi douglasie straniere.
Da quella notte d’inverno avevo imparato molto. Mi sbagliavo quando pensavo che la caduta di tanti di noi alberi sarebbe stata la fine per quel bosco. Anzi era solo l’inizio e, ora ne sono certo, molto ancora dovrà accadere in questo spettacolo in continuo movimento che è la natura.
Il legno morto è vitale per le foreste, per le molteplici funzioni che svolge.
Questo racconto ambientato nell’abetina del Cerro di Pietramala ne è un piccolo esempio. Per approfondire, vi consiglio di dare un’occhiata a questo bel sito: www.forestbeat.it
Per fotografare gli animali selvatici è stata utilizzata una fototrappola fissa, collocata proprio nell’abetina del Cerro.